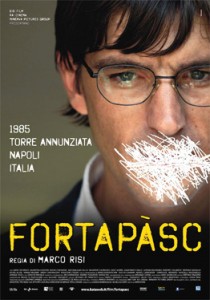Il Mostro di Firenze terrorizzò l’Italia. Gli investigatori hanno brancolato nel buio per quasi due decenni, dal ’68 all’84. Sono stati commessi 8 duplici omicidi. Impensabile proporre senza edulcorazioni una fiction di questo tipo in Italia. La Rai e Mediaset ne avrebbero fatto una storia d’amore, con tanto di lieto fine.
Il Mostro di Firenze terrorizzò l’Italia. Gli investigatori hanno brancolato nel buio per quasi due decenni, dal ’68 all’84. Sono stati commessi 8 duplici omicidi. Impensabile proporre senza edulcorazioni una fiction di questo tipo in Italia. La Rai e Mediaset ne avrebbero fatto una storia d’amore, con tanto di lieto fine.
Purtroppo (ma solo perché sono da soli) Fox Channel Italy si conferma essere l’unica vera rete italiana che investe in prodotti cinematografici di qualità, coraggiosi e senza troppe autocensure, vero problema della tv generalista italiana, una tv che non si censura di fronte a talk show che rasentano il feticismo, ma che nella finzione (fiction) vuole raccontare solo storie d’amore buoniste in cui i cattivi sono sempre delle macchiette.
Il Mostro di Firenze (fiction) fa paura come lo fece nella realtà. Chi ricorda quel periodo, rivedendo la serie tv in sei puntate le cui prime due sono state trasmesse giovedì 12 novembre da Fox, non può non ricordare le emozioni, i timori, l’angoscia di quel periodo in cui si aveva persino paura uscire di casa.
Il regista Aurelio Grimaldi di orrore se ne intende. Non avevo molta fiducia in un suo successo dell’operazione, ma è riuscito a trasportare quell’angoscia di “Caos calmo” anche in questa storia. Un prodotto tv che finalmente diventa cinema. Certo non perfetto, anche a causa degli attori non sempre all’altezza, come Nicole Grimaudo “monoblocco” che sembra appena uscita da una puntata di Ris – Delitti Imperfetti in cui tutti gli attori recitano con lo stesso tono e la stessa faccia.
Il mostro di Firenze rimane comunque un buon prodotto, una serie tv che, almeno alle prime puntate, promette molto bene. Anche per il futuro della serie tv italiana. Fox aveva già dato dimostrazione di saperci fare con Romanzo Criminale, la serie. Ora il Mostro. Le tv generaliste o cambiano stile (recitazione, regia, ripresa, fotografia) oppure è meglio si mettano a produrre telenovelas, per utilizzare volutamente un termine anni ’80: soap opera o serial sarebbe già un complimento.



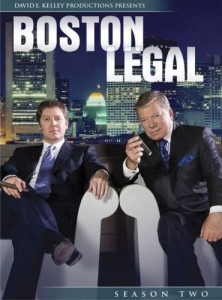 L’altro giorno un amico mi ha detto che non condivide che io abbia scritto che non ci siano fiction italiane “belle”.
L’altro giorno un amico mi ha detto che non condivide che io abbia scritto che non ci siano fiction italiane “belle”.