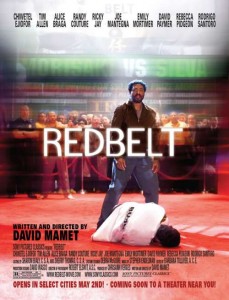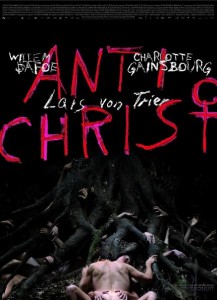Un’opera cinematografica non si giudica dal suo consenso al botteghino. È vero. Ma se a dirlo, come nel caso del Barbarossa, sono gli stessi leghisti che attaccavano, e attaccano, il cinema che prende finanziamenti pubblici e non incassa, le affermazioni sembrano quantomeno rivoltare la frittata a seconda di quale parte si vuole bruciare.
Molte le polemiche che hanno accompagnato l’uscita del film. Vi è sicuramente entrata troppa politica. Non certo per le critiche “di sinistra”, ma per la promozione che ne ha fatto il popolo padano, a partire dai suoi colonnelli.
Proviamo a dimenticare tutto. Renzo Martinelli, il regista, ha dichiarato che un film va giudicato dalle emozioni che è capace di suscitare, che deve avere una funzione maieutica, far pensare, che vada giudicato solo come un film. Bene. Quindi proviamo a utilizzare questi parametri.
Barbarossa non suscita emozioni. O meglio ne suscita molte in chi è predisposto ideologicamente a voler vedere una rivolta contro gli invasori, a chi li vuole vedere decapitati. Il film inizia bene, abbandona gli stilemi della fiction televisiva. Ma l’illusione dura poco. Ben presto entrano in gioco gli echi della “libertà” a tutti i costi. I personaggi diventano macchiette. Alberto Da Giussano non ha alcuna motivazione per combattere, non ha un conflitto interiore che lo porti ad essere alla guida della Compagnia della morte, non ha una ferita che lo spinga a fare quel che fa (se non a metà film quando muoiono i fratelli). Come se rappresentare i fatti di una storia bastasse a giustificare svolte narrative.
Barbarossa ha il grande difetto di essere stato realizzato pensando già a un pubblico di riferimento. Altroché Braveheart, grande film di Mel Gibson. Qui si raccontava una vera ribellione, di un eroe diventato tale suo malgrado, il cui scopo di vendetta è diventato motivo di libertà per molti, fin da subito gli viene ucciso il padre e, con estrema cattiveria, anche l’amata. Alberto da Giussano non è niente di tutto ciò: confonde la pazzia con la ribellione, riuscendo persino in un finale televisivo in cui l’amore trionfa a tutti i costi, anche a scapito di una narrazione. Se Mel Gibson venne accusato di megalomania, di voler diffondere un integralismo cristiano, almeno aveva realizzato un’opera che parlava al mondo intero, non a una nicchia.
La seconda parte del film inoltre (e qui si vede già l’impianto pronto per la suddivisione in due puntate da fiction) potrebbe esistere da sé, senza tutto il lungo preambolo della distruzione di Milano. Sebbene sia la parte più interessante è invece la parte più fredda, in cui le motivazioni dei personaggi vengono lasciate da parte dando eccessivo risalto alla battaglia di Legnano e al giuramento di Pontida che gli spettatori in sala attendono con ansia, a scapito di una storia che non emoziona.
Torniamo al contesto storico in cui è stato realizzato Barbarossa. Oggi. È stato detto che Martinelli non è un regista di regime. È vero. Leni Riefenstahl, la regista di Hitler prima della guerra, era una regista di regime. Conosceva l’obiettivo e lo dichiarava, non lo nascondeva dietro finte emozioni. Le sue immagini sono entrate nella storia del cinema. Nonostante l’ideologia che trasmettevano. Lo stesso non sarà per Barbarossa. Sarà proiettato per anni nei circoli della Lega, sarà oggetto di forte marketing, avrà vita lunga. Ma sarà solo uno strumento di propaganda ideologica.



 Gli autori negano, ma la storia è quella di Romeo e Giulietta. La saga di Twilight, i nuovi vampiri che hanno letteralmente fatto impazzire i teen ager di tutto il mondo, è basata sui romanzi di Stephanie Meyer. E nelle sale cinematografiche esce in questi giorni il secondo capitolo dal titolo New Moon. Dopo il successo del primo film, Twilight, costato 35 milioni di dollari incassandone oltre 400 milioni in tutto il mondo, la nuova avventura di Bella ed Edward, lei umana lui vampiro, sembra confermare l’ipotesi che dietro tutto ci sia proprio la storia di Romeo e Giulietta.
Gli autori negano, ma la storia è quella di Romeo e Giulietta. La saga di Twilight, i nuovi vampiri che hanno letteralmente fatto impazzire i teen ager di tutto il mondo, è basata sui romanzi di Stephanie Meyer. E nelle sale cinematografiche esce in questi giorni il secondo capitolo dal titolo New Moon. Dopo il successo del primo film, Twilight, costato 35 milioni di dollari incassandone oltre 400 milioni in tutto il mondo, la nuova avventura di Bella ed Edward, lei umana lui vampiro, sembra confermare l’ipotesi che dietro tutto ci sia proprio la storia di Romeo e Giulietta.  Il
Il